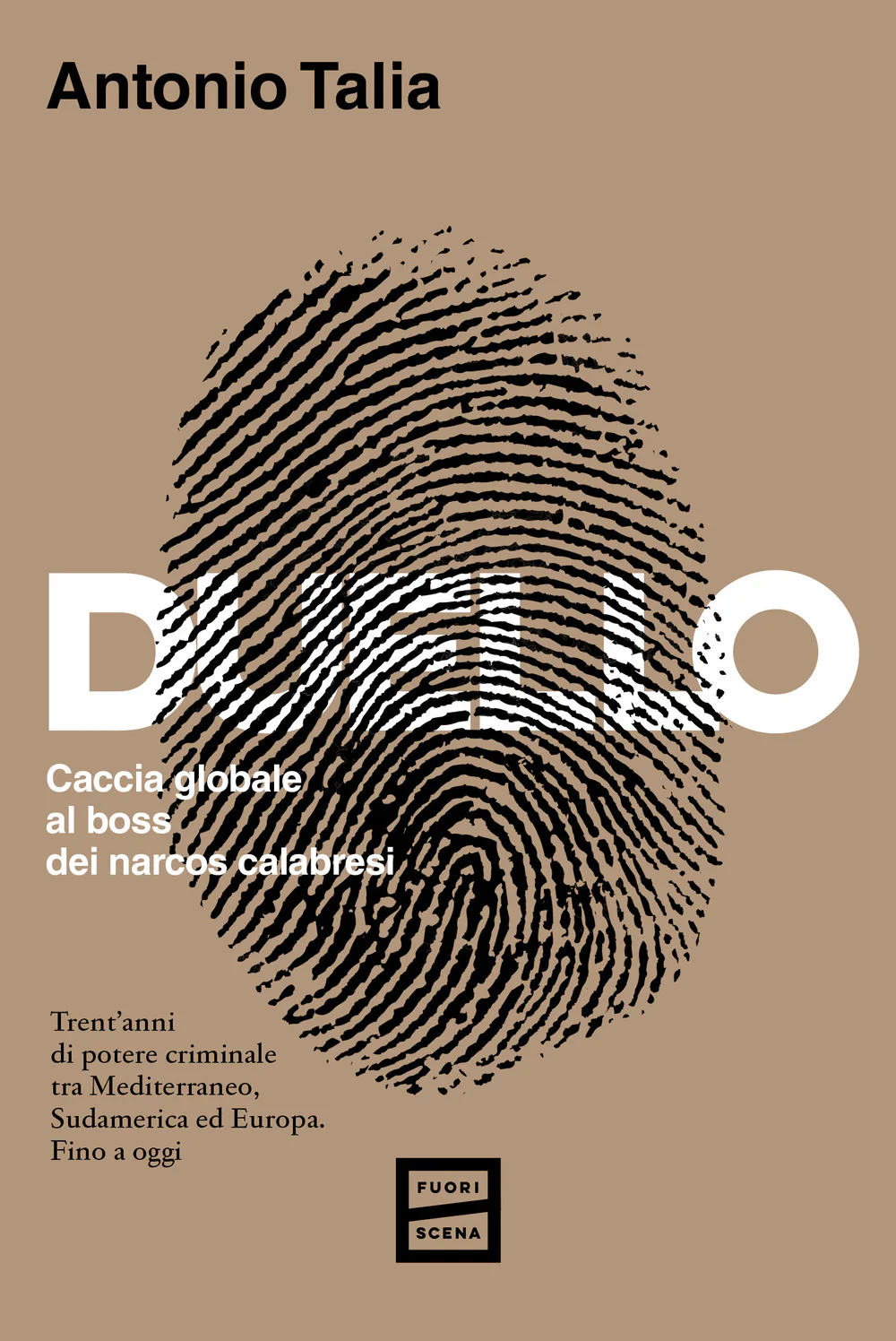
Duello, il nuovo libro di Antonio Talia
La cattura del tamunga Sono passati ormai 4 anni dall’arresto, questa volta definitivo, del boss latitante Rocco Morabito, esponente di spicco della mafia calabrese, conosciuta…


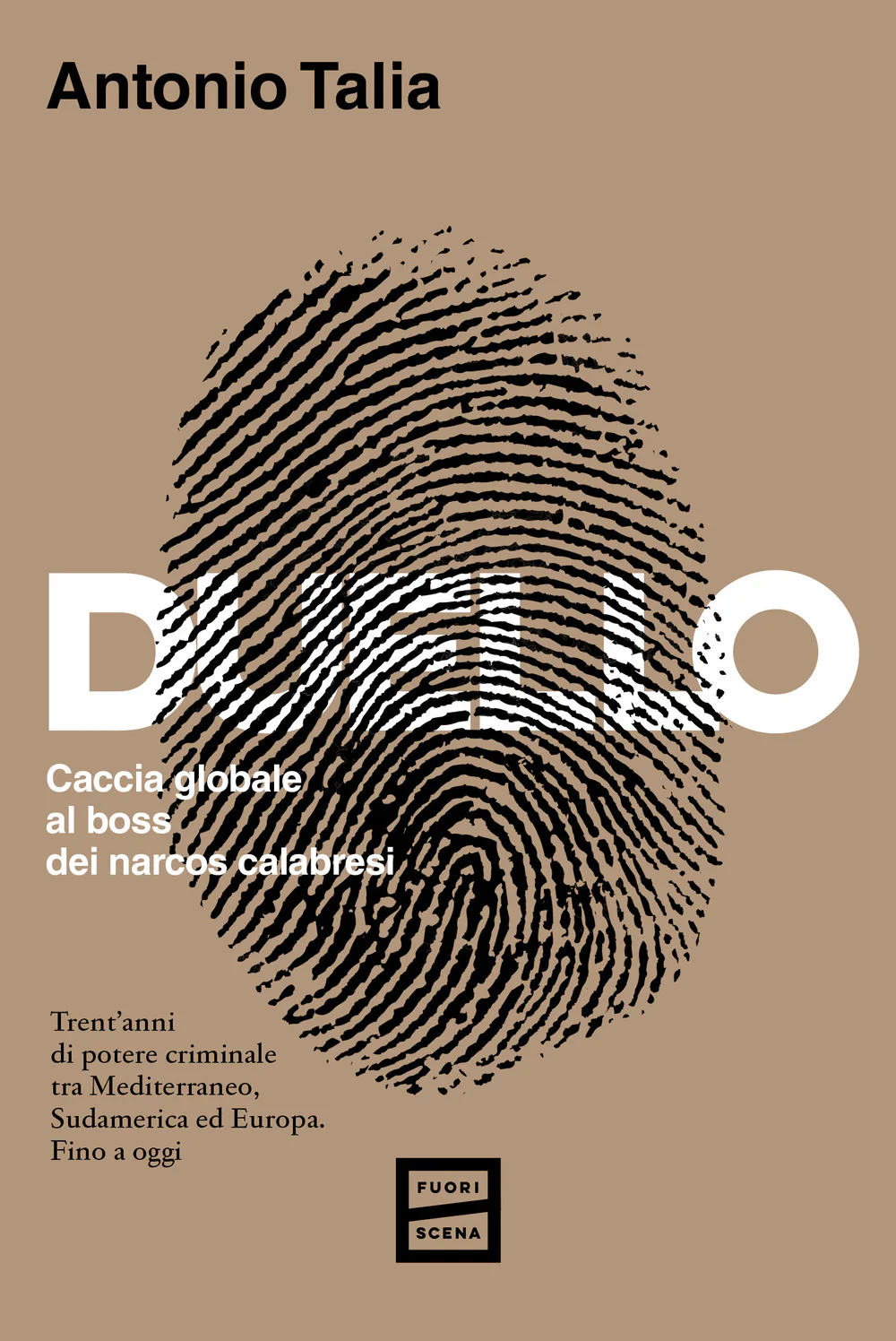
La cattura del tamunga Sono passati ormai 4 anni dall’arresto, questa volta definitivo, del boss latitante Rocco Morabito, esponente di spicco della mafia calabrese, conosciuta…
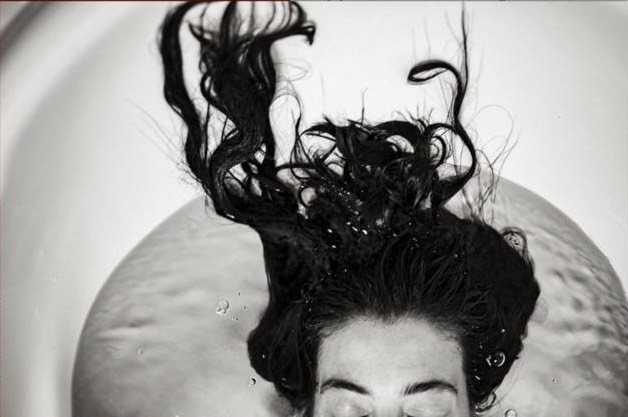
Il 6 Marzo avrà inizio la quinta edizione di Pluralismi – Riflessioni su corpi, politiche e rappresentazioni di genere, il ciclo di seminari sul genere…

Quando il robot Grendizer, creato dal mangaka Go Nagai, arrivò in Italia col nome di Goldrake conquistò i cuori di una generazione, che ancora oggi…

Sono oltre 19 mila le firme raccolte nell’appello lanciato su change.org dagli alunni della 2A dell’Istituto Comprensivo “Enzo Drago” di Messina. Con questa iniziativa, i…

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa e ha visto trionfare Olly, con la sua Balorda Nostalgia, seguito da Lucio Corsi, con…

Si apre un nuovo capitolo sul fine vita in Italia. Lunedì 11 febbraio 2025 la Toscana è la prima regione italiana a garantire l’accesso ai…

L’alienazione di un uomo comune. Voto UVM: 5/5 Il laureato (the graduate) è un film diretto dal grande Mike Nichols nel 1967. Il maestro Nichols…

Eccoci nel vivo dell’edizione 2025 di Sanremo, il Festival vede il ritorno di Carlo Conti alla conduzione con la straordinaria partecipazione di Gerry Scotti. Prime…

Il caso di Najeem Osama Almasri, noto come Almasri, ha acceso un vivace dibattito in Italia e a livello internazionale. La sua vicenda coinvolge questioni…