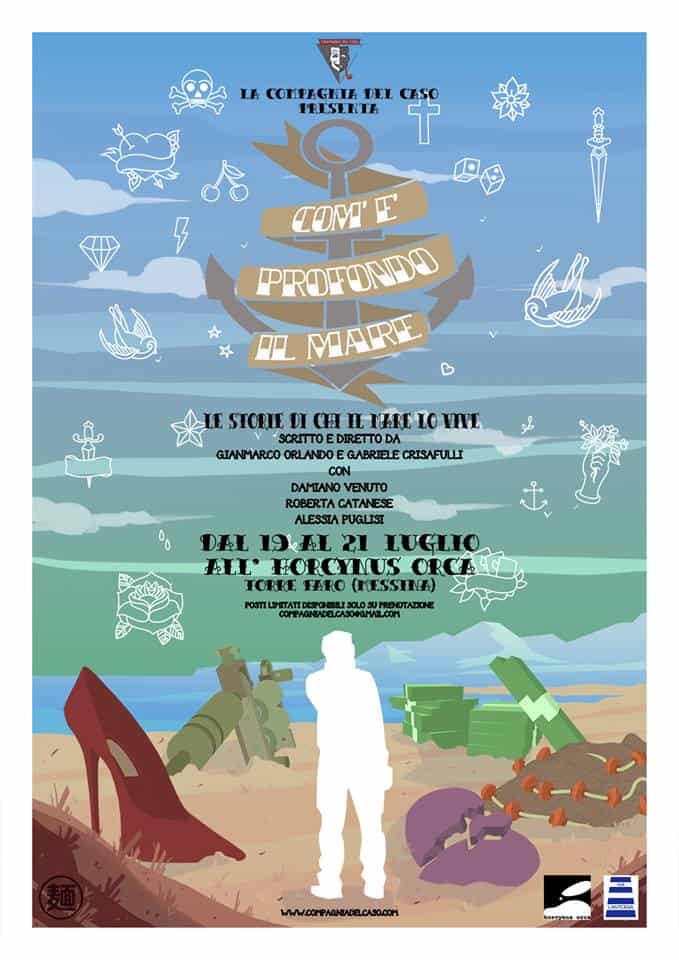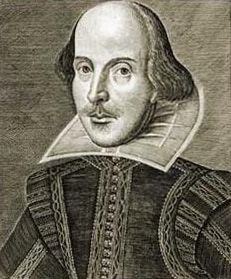Solidarietà e arte si fondono in un tripudio di bellezza grazie allo spettacolo teatrale “Otto storie di giornalisti eroi”
Molteplici forme d’arte si sono coniugate sabato 22 settembre presso il Salone della Borsa della Camera di Commercio di Messina, in occasione della messa in…