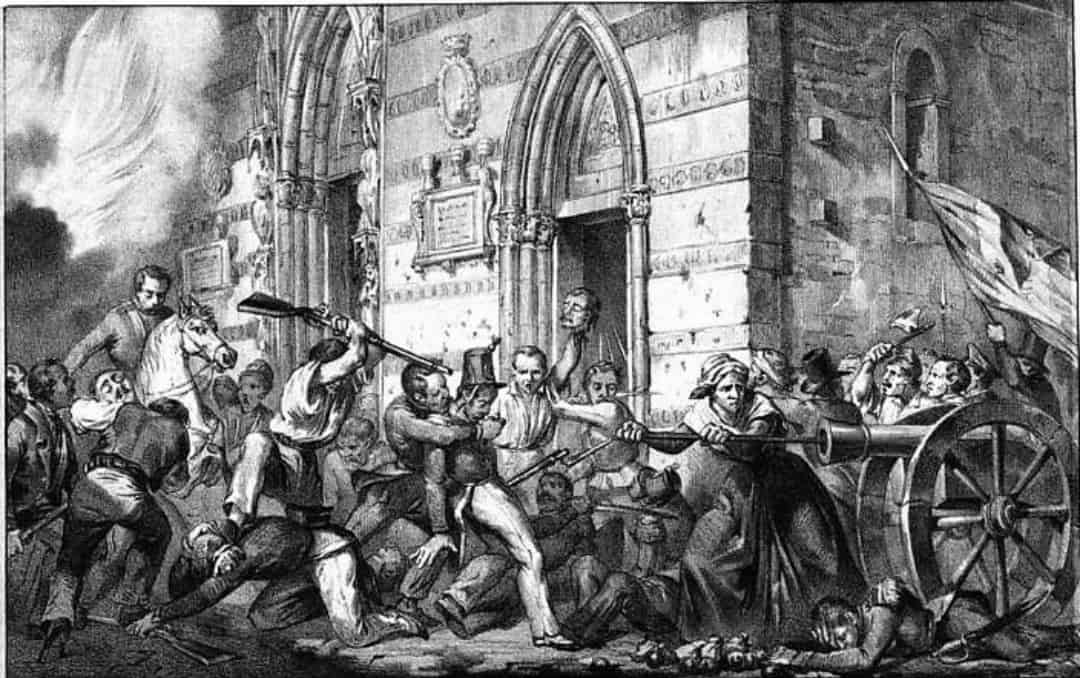Nessuna immagine disponibile
15 maggio 1946, la nascita della prima regione italiana: la Sicilia
Le regioni sono ormai elementi fondamentali e imprescindibili nell’assetto istituzionale della Repubblica Italiana. Non tutti sanno, però, che la regione, quale ente territoriale con poteri…