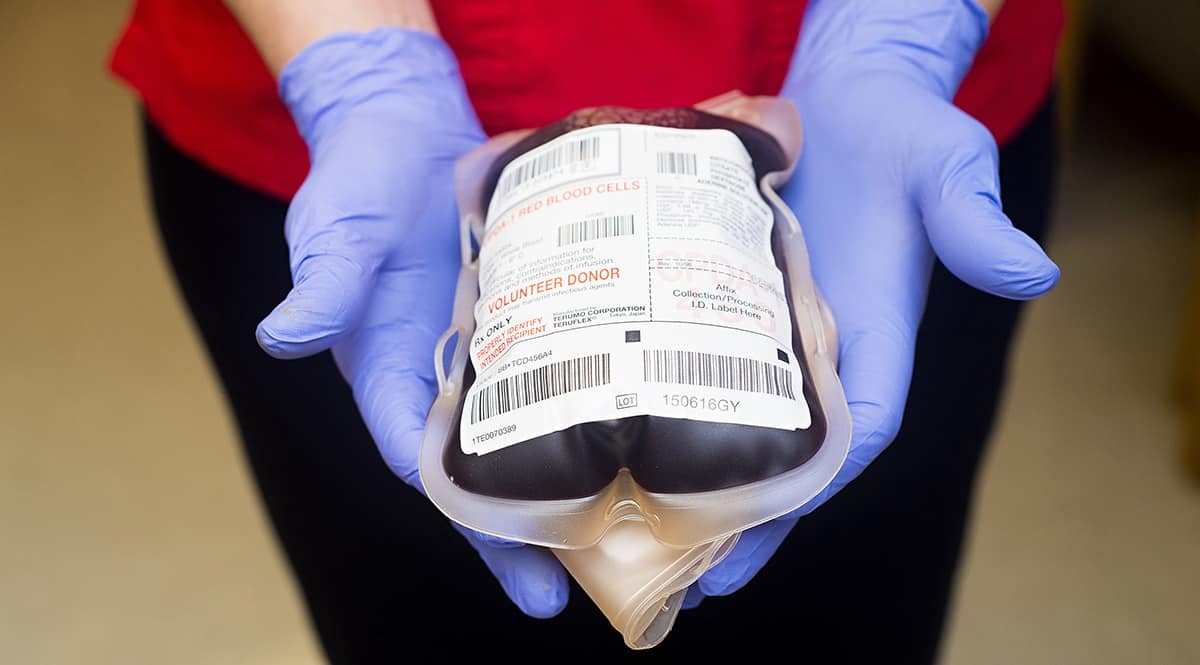Si può predire l’aggressività di un soggetto osservandone il volto?
Il volto è ciò che principalmente ci contraddistingue: piccole differenze nei tratti facciali possono suscitare reazioni diametralmente opposte in un osservatore. L’attrazione, la fiducia o…