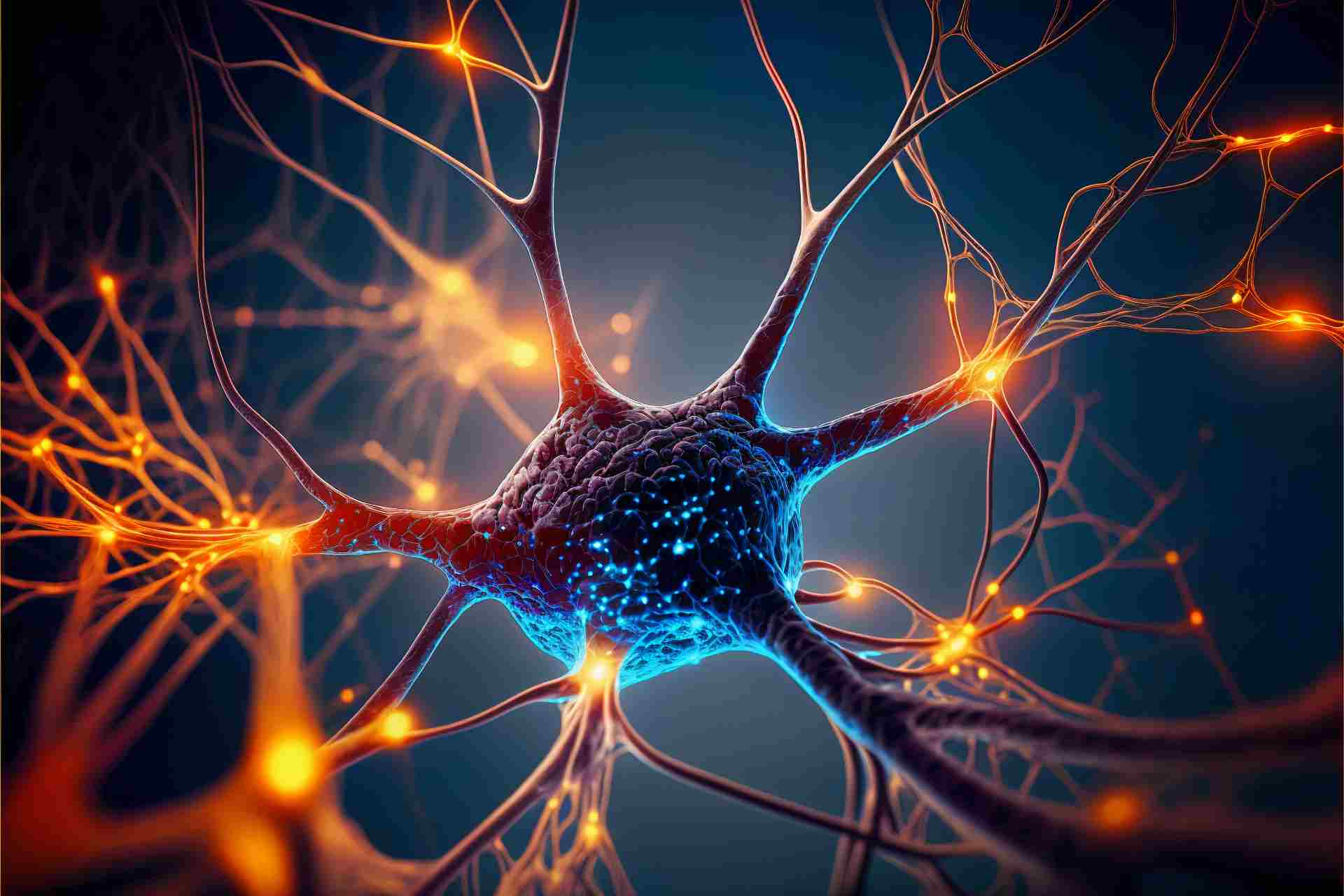
Rigenerazione del sistema nervoso: le applicazioni della nanomedicina
La medicina non ha mai smesso di progredire, poiché la scoperta di nuove malattie cammina di pari passo con le strategie intraprese per curarle, per…


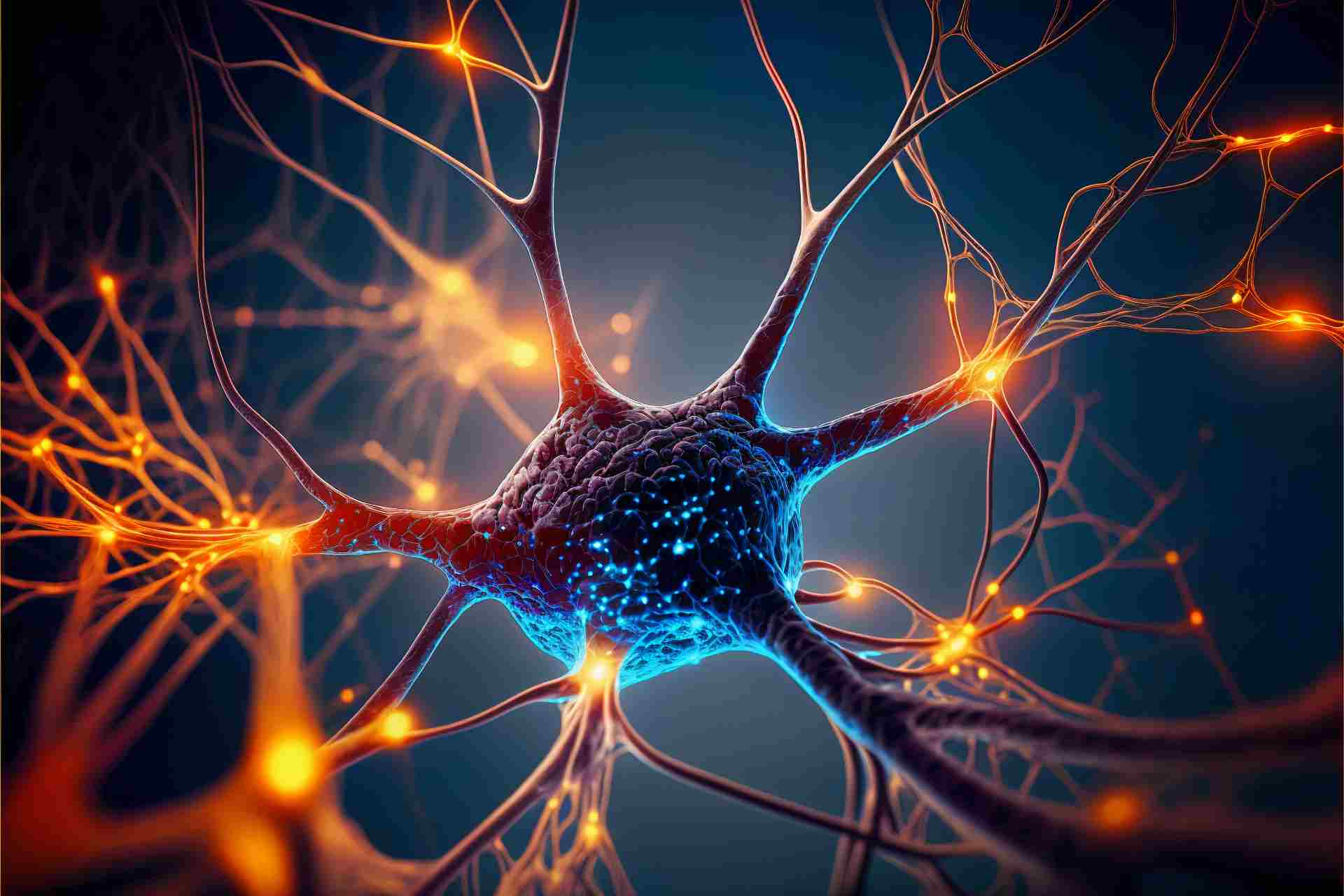
La medicina non ha mai smesso di progredire, poiché la scoperta di nuove malattie cammina di pari passo con le strategie intraprese per curarle, per…

Si dice spesso che il futuro sia in mano alle nuove generazioni. Noi di UniVersoMe, da giovani redattori, crediamo fermamente in quest’assunto, a tal punto…

Ogni anno, in Italia, si verificano circa 120 mila casi di infarto miocardico acuto, il classico “attacco di cuore”. La mortalità per questo evento si aggira…