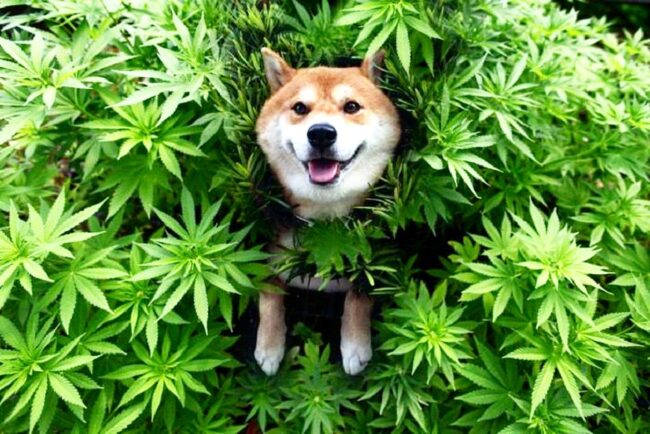Convegno “Mafie tra continuità e mutamento: analisi, esperienze, narrative”: intervista alla dott.ssa Rossella Merlino
Nei giorni 27 e 28 settembre si svolgerà il convegno “Mafie tra continuità e mutamento: analisi, esperienze, narrative” presso l’Aula Magna del Rettorato. L’evento rientra nell’ambito del progetto…