
racconti

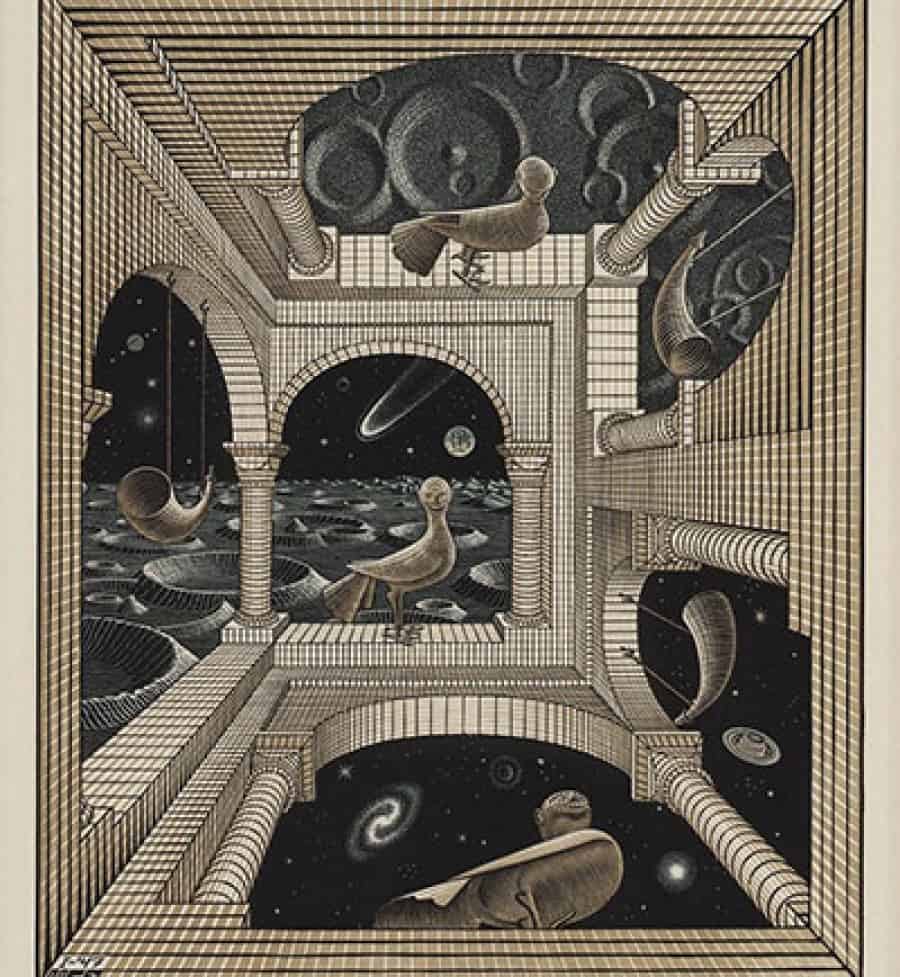
La sentenza
Stando attento a non essere notato, mi inoltrai all’interno del palazzo che mi era stato indicato da Joseph. Secondo le sue istruzioni, avrei dovuto salire…
L’importanza della vita e della morte
Il nostro racconto comincia in una casa calda e accogliente dell’Arizona. È una giornata particolarmente cupa e, sorseggiando una tazza di buona cioccolata calda, Mortimer…
Dieci racconti, dieci punti di vista sulla città. “Cara Messina ti scrivo…”
Attribuire il valore ad una città servendosi della scrittura. Giovanni Pascoli, citato ad apertura del volumetto, diceva: “dove è quasi distrutta la storia resta la…
Arrivare
Corro senza sosta: fortunatamente ho deciso all’ultimo minuto di mettere le sneakers. Mi trascino dietro un trolley rosa e piccolo, forse talmente tanto da avere il…
Tutta colpa della mia città, mi ha reso debole e inadeguata
Non so se sia il caso di dire “finalmente me ne vado da qui”. In realtà non sono mai stata malissimo in questo posto, ma…

Twice – Alle spalle del nuovo mondo
– Capitolo 1 Dalle fogne in cui stavamo non ne sarebbe uscito mentalmente vivo neanche un pazzo. Gargan portava le casse di birra…

Momenti
Come coriandoli, rossi di passione, neri di dolore, rosa di dolcezza, gialli di felicità, blu di tranquillità, verdi di speranza, grigi di tristezza. Prendine un…

Appuntamento eterno
Sono sempre qui dieci minuti prima. È la mia routine, è d’obbligo. Il portone in legno d’ingresso è quasi invisibile, coperto da quella trentina di…
