Dramma d’amore
un testo rap poetico molto personale, scritto per guarire un cuore rotto.


un testo rap poetico molto personale, scritto per guarire un cuore rotto.
Dicembree illuminavii viali di stinti ricordiognunodel secondo precedente Ho provatoa incollarlicon il biadesivoa inalare il liquido di sviluppoa cercartinei più cremisi angolidella camera oscuraVolevo leggere…

La città che odora di spezie Di tè alla mela e baklava col miele La città dei canti all’ora della preghiera due moschee rispondono al…
Nella mentela malinconia,a dover rimarginarsiè rimasta la ferita.Il nostro legamel’ha portato viail vento improvviso.Hai colpito il mio cuoree ne hai fatto polvere,hai frantumato i ricordie…
Questa domenicami sento nemicadi me stessapersa in un’essenzadi pensierinegativiora e ieridiventano il futurodi un muro davanti a medi felicità sempre a metà Questa domenicain una…
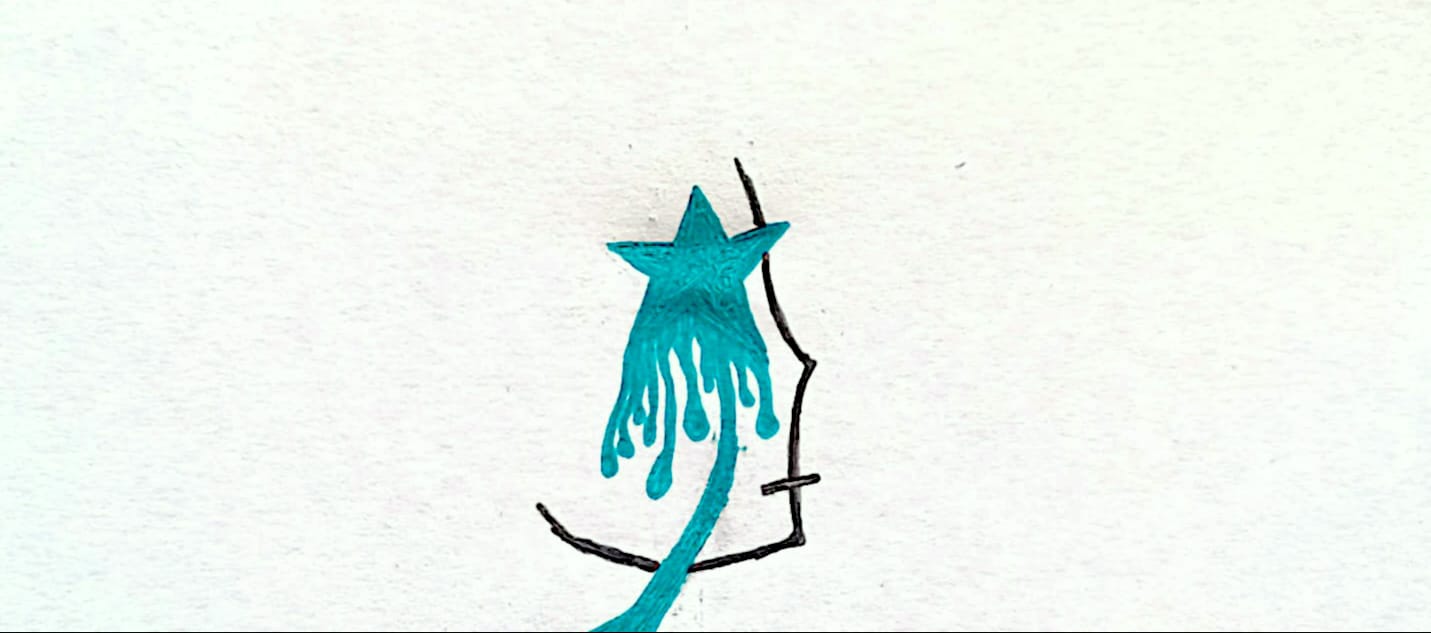
Combattere il disgusto di un nuovo acquistoIl magnetismo di un tozzo di paneNutrito dalla farina di un altro saccoUso le poche parole che soChe hoPer…
Raccolse il cellulare, lo sbloccò e guardò.Quando la vide il suo cuore sussultò, come era sempre stato.Indossò le cuffie, lo faceva sempre quando voleva riflettere,…
In questa terra arida che era la mia vita, hai scavato a fondo con le dita una buca dritta e profonda, che hai riempito con…
La mia passeggiata era accompagnata dal vermiglio Oleandro e la sua bellezza mi ripagava di tutti gli sforzi fatti per raggiungerlo. Di consueto, quel luogo,…