
UniMe: ancora riconoscimenti a livello internazionale
L’Università di Messina ed i suoi docenti, continuano ad ottenere prestigiosi risultati che portano luce in questo periodo buio di pandemia. I traguardi raggiunti Nell’ultimo…



L’Università di Messina ed i suoi docenti, continuano ad ottenere prestigiosi risultati che portano luce in questo periodo buio di pandemia. I traguardi raggiunti Nell’ultimo…

In sintesi: Cos’è e come funziona la proteina Spike dei Coronavirus? Come funziona il vaccino Pfizer-BioNTech? Il vaccino ci protegge anche dalle varianti del virus?…

L’Italia non è un Paese per giovani, e la pandemia in corso ne da ulteriore conferma. Scarsa considerazione è stata data a chi rappresenta il…
La riflessione di oggi nasce spontaneamente. Potremmo dire, con estrema semplicità, dal periodo che stiamo vivendo. Con mobilità e socialità ridotte al minimo sempre più…

Il COVID-19 ha intaccato, modificato e stravolto la nostra quotidianità. Un po’ ovunque nel mondo ci sentiamo soli, non siamo liberi di circolare tranquillamente e…

Il mese di dicembre, da tutti, viene inevitabilmente associato al Natale: si inizia a percepire un’atmosfera magica, di festa, di gioia, si incontrano i familiari…
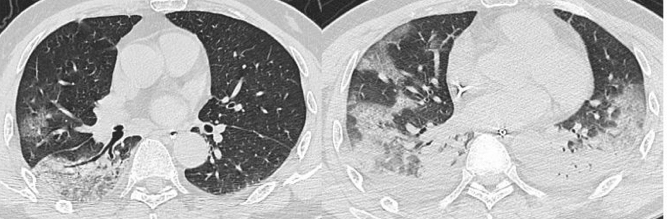
Asintomatici sani? “Pericolosa bugia”. Esordisce così Roberto Burioni sul blog scientifico Medical Facts. Ma cosa spinge l’esperto, come molti altri del settore, a sbilanciarsi in maniera…

Dall’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, e dei famosi 21 parametri in base ai quali giudicare la situazione epidemiologica in una data regione, numerosi esperti hanno…

Una soluzione semplice ad un fenomeno così complesso, come la pandemia da SARS-nCOV-2, farebbe gola a molti. Il vaccino, talvolta figlio di un profondo scetticismo,…