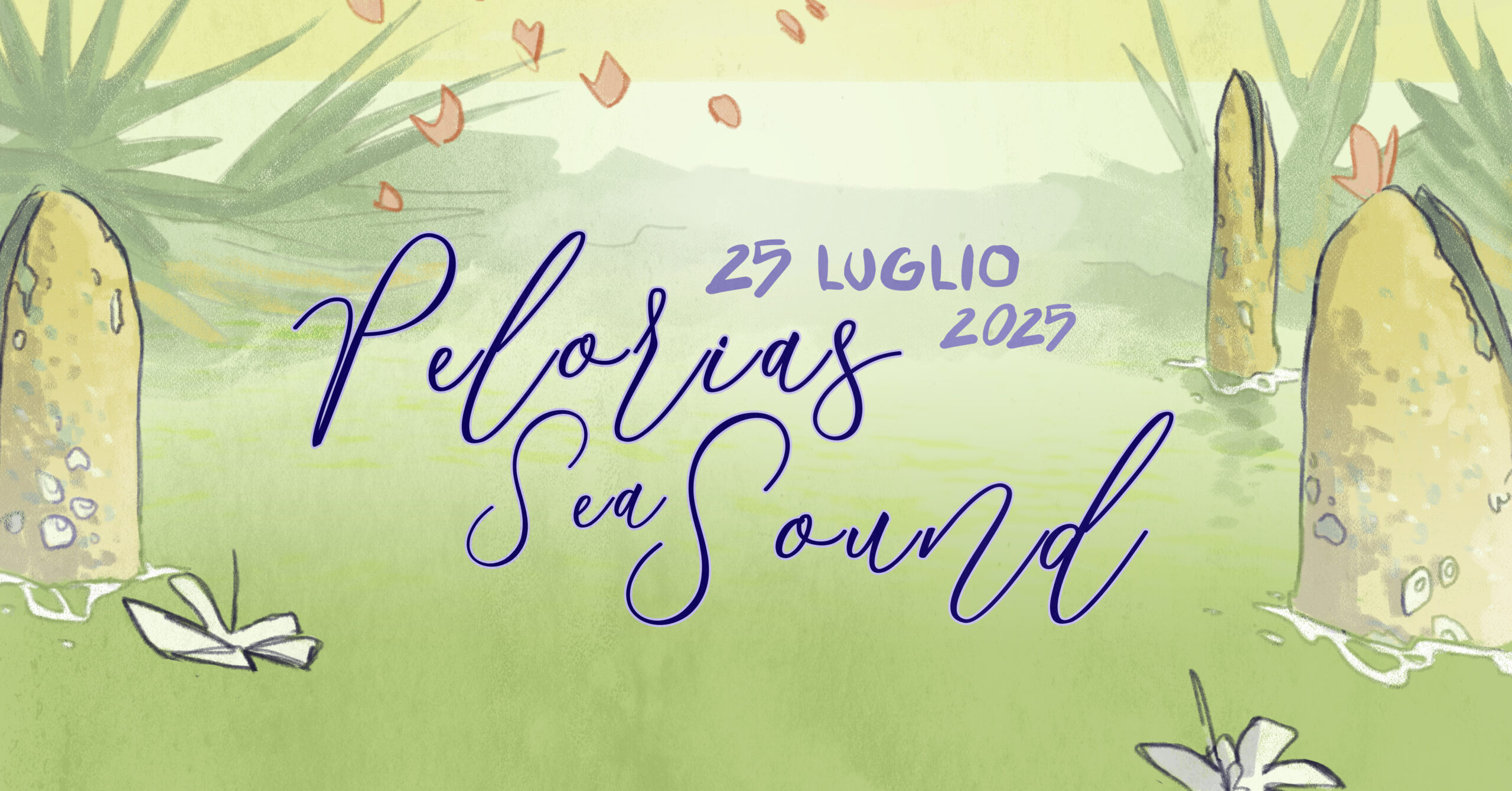
Pelorias Sea Sound: la leggenda che suona ancora a Capo Peloro
Nel punto più orientale della Sicilia, dove il mare si restringe come una ferita sottile tra due terre, c’è un luogo che ha la forza…


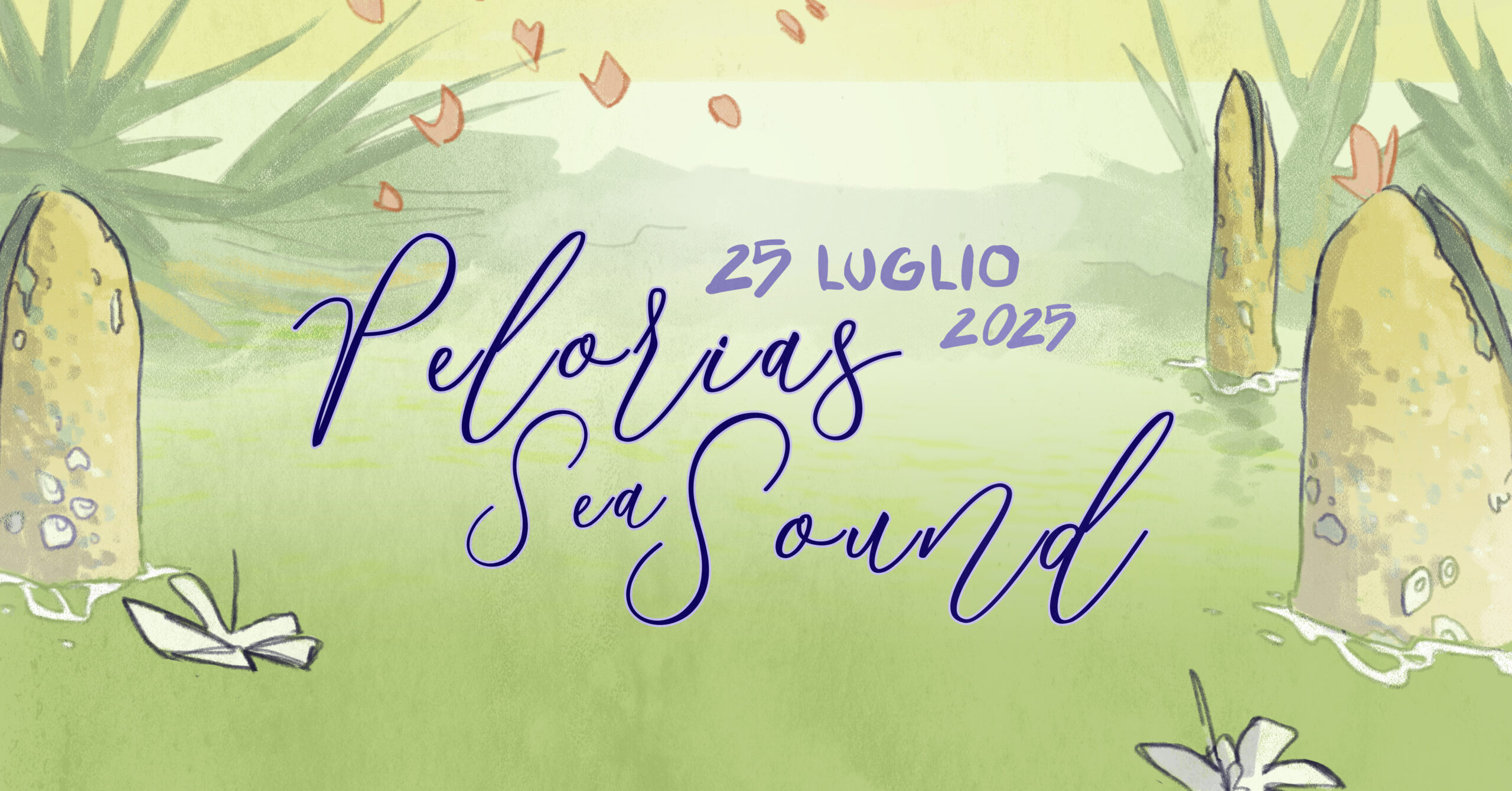
Nel punto più orientale della Sicilia, dove il mare si restringe come una ferita sottile tra due terre, c’è un luogo che ha la forza…

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa e ha visto trionfare Olly, con la sua Balorda Nostalgia, seguito da Lucio Corsi, con…
Sì è svolto giorno 12 aprile al Dicam l’incontro con l’antropologa Macrina Marilena Maffei, autrice dell’opera La maga e il velo. Incantesimi, riti e poteri…

La Sicilia è da sempre terra di miti e leggende: ci siamo mai chiesti però cosa ci sia alla loro origine? Fin dalla notte dei…

In questa nuova tappa di Messina da scoprire vogliamo raccontarvi di come i fili che tessono le trame di leggende remote si intreccino alle vicende…