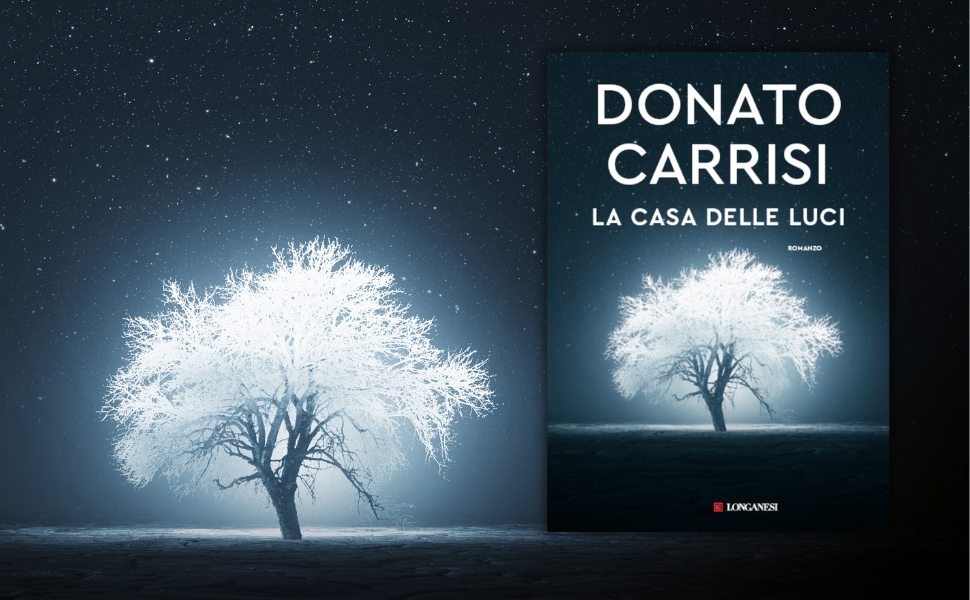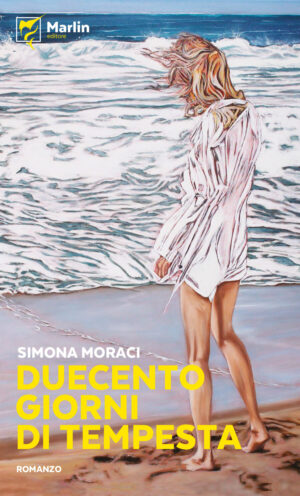Il genio comico di Nino Frassica: presentato il suo ultimo libro “Piero di essere Piero”
Sabato 21 dicembre, l’Aula Magna del Rettorato ha ospitato la presentazione dell’ultimo libro dell’attore comico messinese Nino Frassica, dal titolo Piero di essere Piero, organizzato…