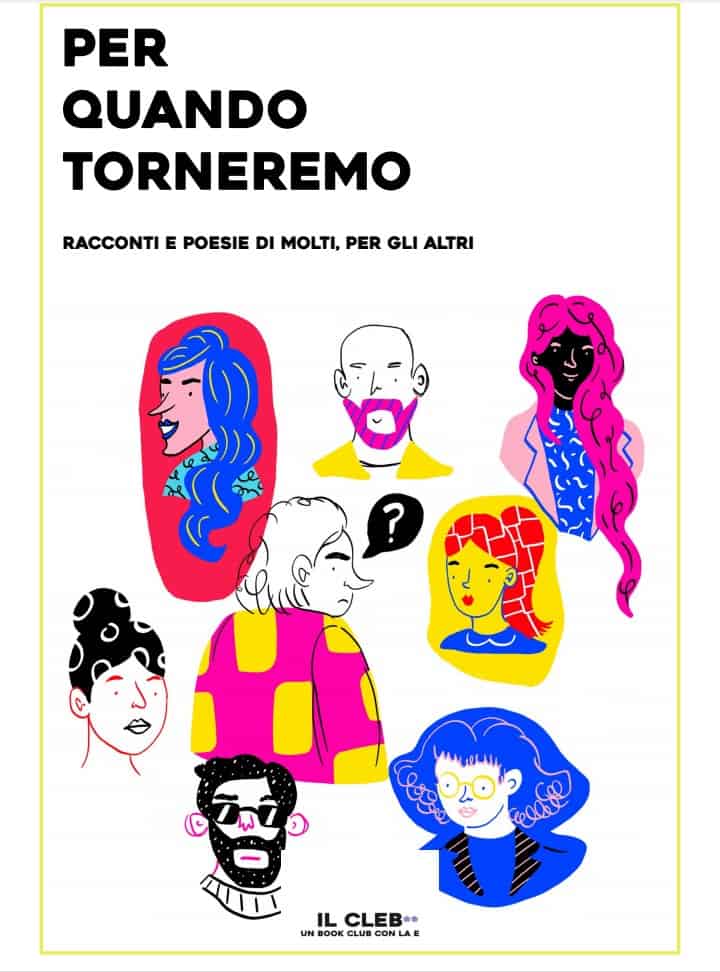
Per quando torneremo: letteratura e solidarietà contro il Coronavirus
Può l’arte – e in particolar modo la letteratura – lanciare un messaggio di speranza in un periodo buio come questo? Può trasmettere quel senso…


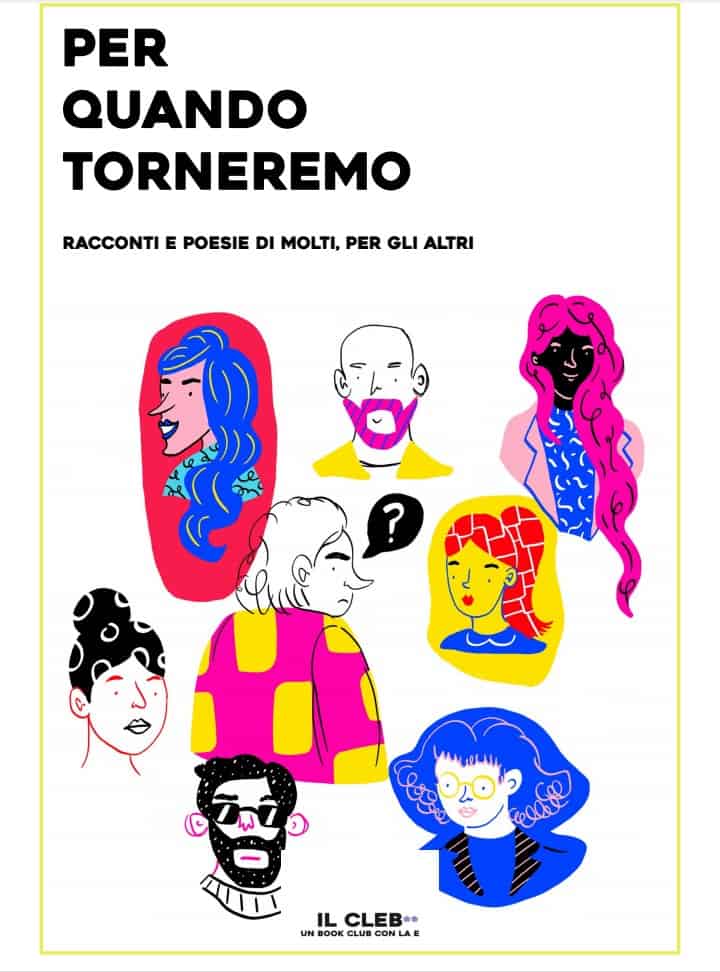
Può l’arte – e in particolar modo la letteratura – lanciare un messaggio di speranza in un periodo buio come questo? Può trasmettere quel senso…
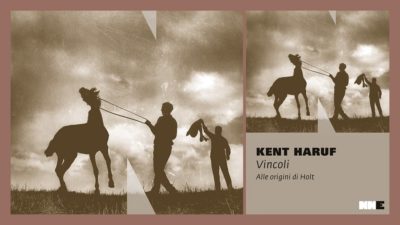
Giovedì 11 aprile 2019. Messina. Via Giuseppe Garibaldi, 56. Libreria La Gilda dei Narratori. Un’immersione nelle atmosfere del Midwest statunitense. Partendo dai romanzi senza tempo…
Eugenio Corti nasce a Besana in Brianza nel 1921. Sin da giovane avverte il fascino della letteratura e coltiva la…

Mercoledì 27 marzo, alle ore 17, nell’Aula Magna del Rettorato, si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione del 290° Anno Accademico dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Prima celebrazione…

Il Silenzio di chi ama è un libro scritto nel gennaio 2018 da Davide Romagnoli, ragazzo di 19 anni studente di scienze della comunicazione all’Università…
Una sequenza di capolavori restaurati, da Luchino Visconti a Elio Petri, ispirati ai romanzi dei grandi autori siciliani La programmazione del cinema Multisala Apollo, dal…
Alda Merini, una poetessa dalla sensibilità elevata, simbolo, anche, del malessere degli individui; malessere che per lei aveva come paracadute soltanto la poesia. Alda Merini…
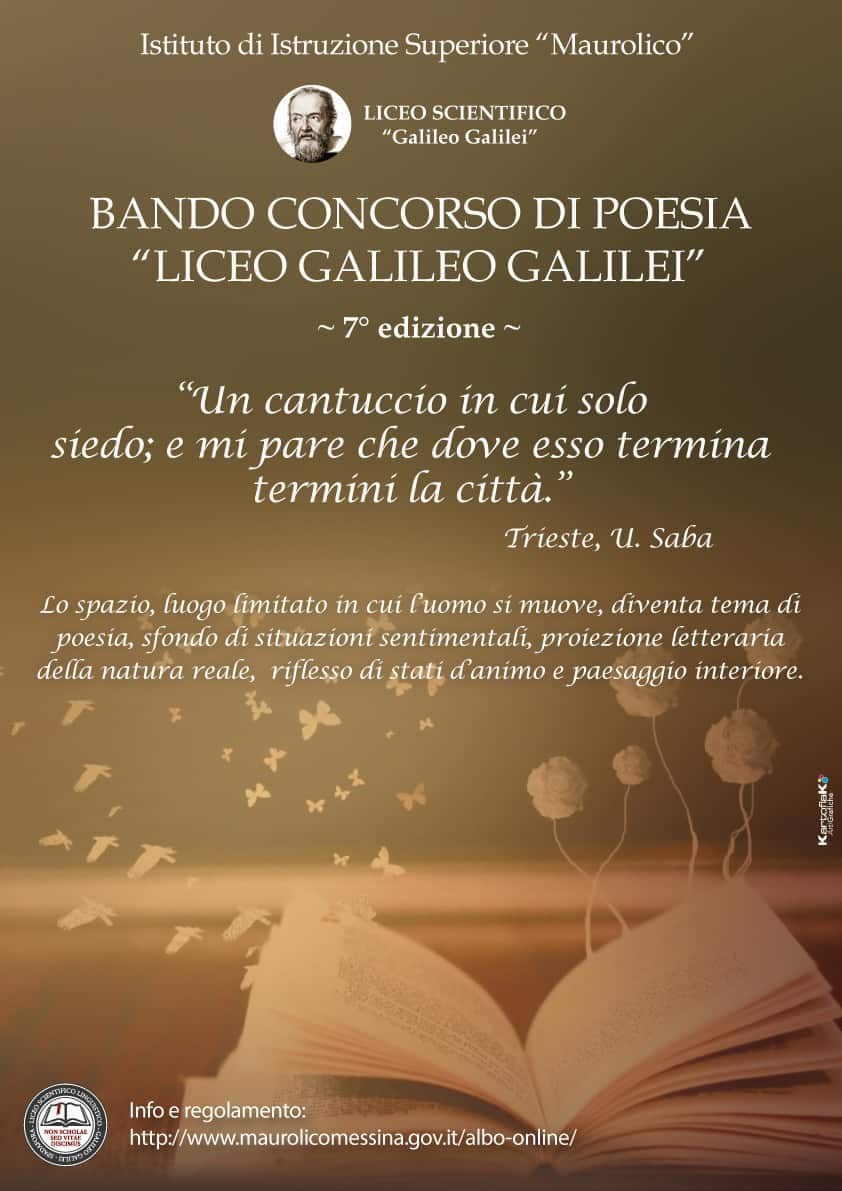
Oramai giunto alla sua 7^ edizione, anche per l’anno scolastico 2018/2019, il Liceo Scientifico-Linguistico “G. Galilei” di Spadafora bandisce l’annuale Concorso di Poesia intitolato all’omonimo…
Attribuire il valore ad una città servendosi della scrittura. Giovanni Pascoli, citato ad apertura del volumetto, diceva: “dove è quasi distrutta la storia resta la…