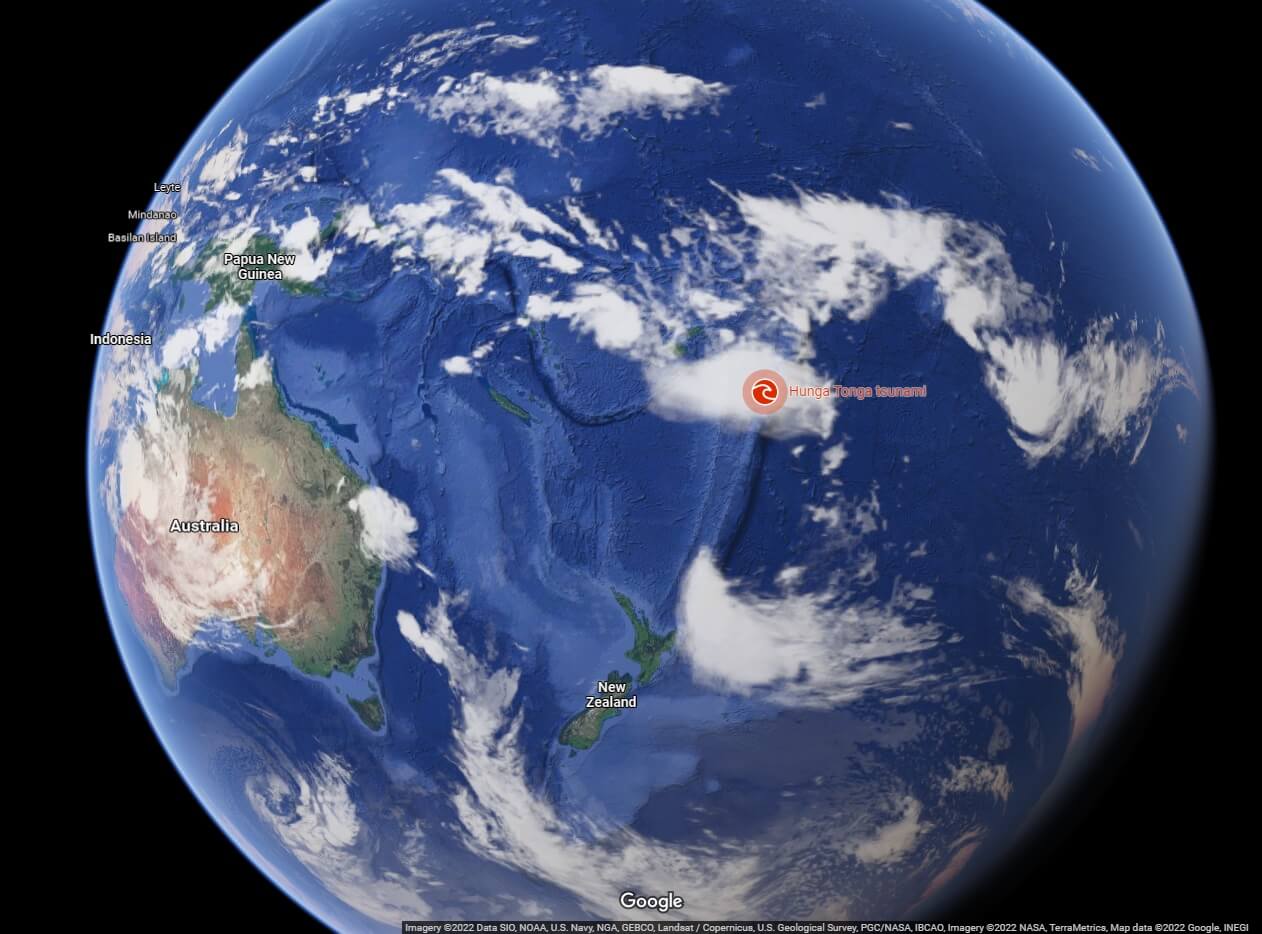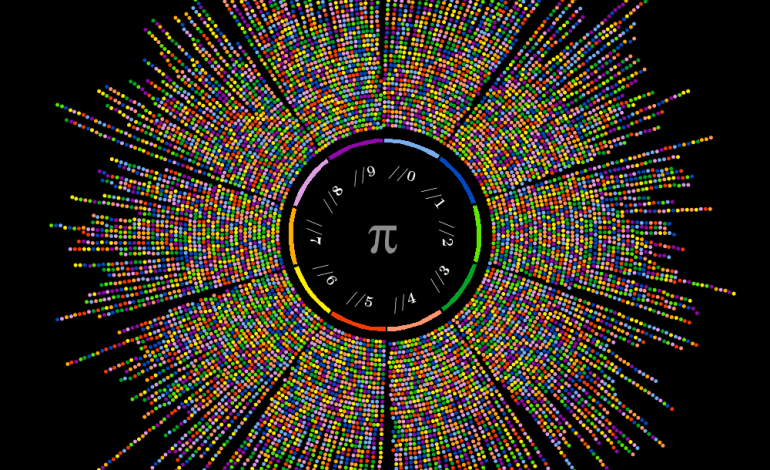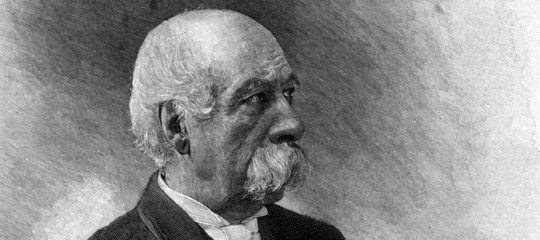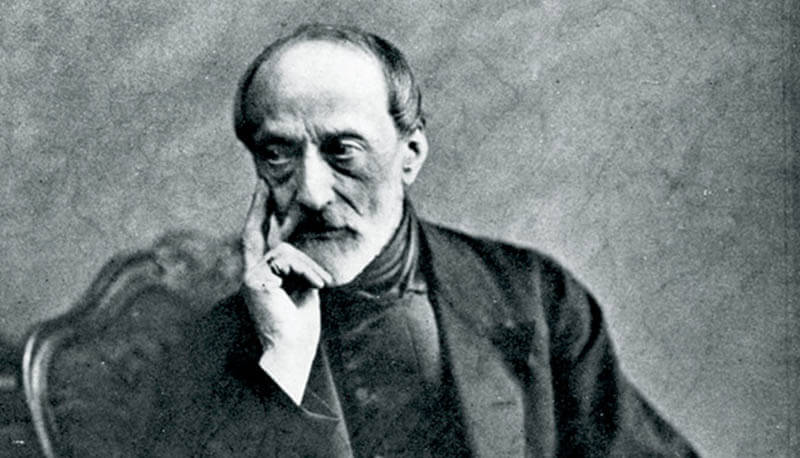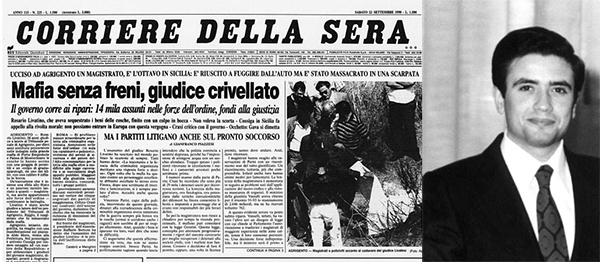Treno deragliato in Ohio, c’è il rischio di uno dei peggiori disastri ambientali degli ultimi anni
Il 3 febbraio in una cittadina nell’Ohio (Stati Uniti) un treno contenente vagoni carichi di sostanze chimiche altamente tossiche è deragliato, uscendo dai binari e…