
Il sogno
Cos’è un sogno? Il sogno, dal latino somnium, è un fenomeno psichico legato al sonno e in particolare alla fase REM, detta anche sonno del paradosso o pensiero notturno…



Cos’è un sogno? Il sogno, dal latino somnium, è un fenomeno psichico legato al sonno e in particolare alla fase REM, detta anche sonno del paradosso o pensiero notturno…
Dal paradosso di Zenone fino alla critica kantiana, dal mistero della caverna di Platone fino al Velo di Maya e anche più in là nel…
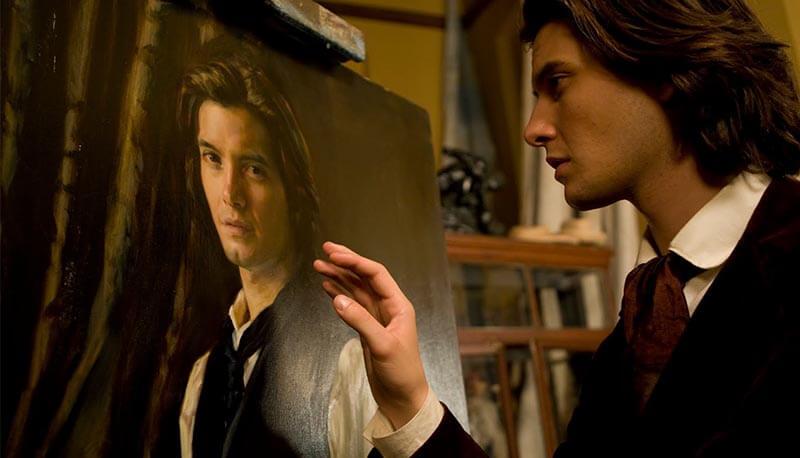
Nella normalità del sano amor proprio che tutti gli esseri umani dovrebbero avere ci si può imbattere in soggetti che, a causa di un disturbo…
Un uomo durante la sua vita, sogna in media circa sei anni. I sogni diminuiscono con l’avanzare dell’età. Sebbene il sogno sia una funzione fisiologica…