
Perché Blade Runner 2049 diventerà un cult?
Blade Runner, diretto da Ridley Scott (Alien, Legend, Il gladiatore, Sopravvissuto – The Martian) uscito nelle sale nel lontano 1982, è l’esempio di come, a volte,…



Blade Runner, diretto da Ridley Scott (Alien, Legend, Il gladiatore, Sopravvissuto – The Martian) uscito nelle sale nel lontano 1982, è l’esempio di come, a volte,…
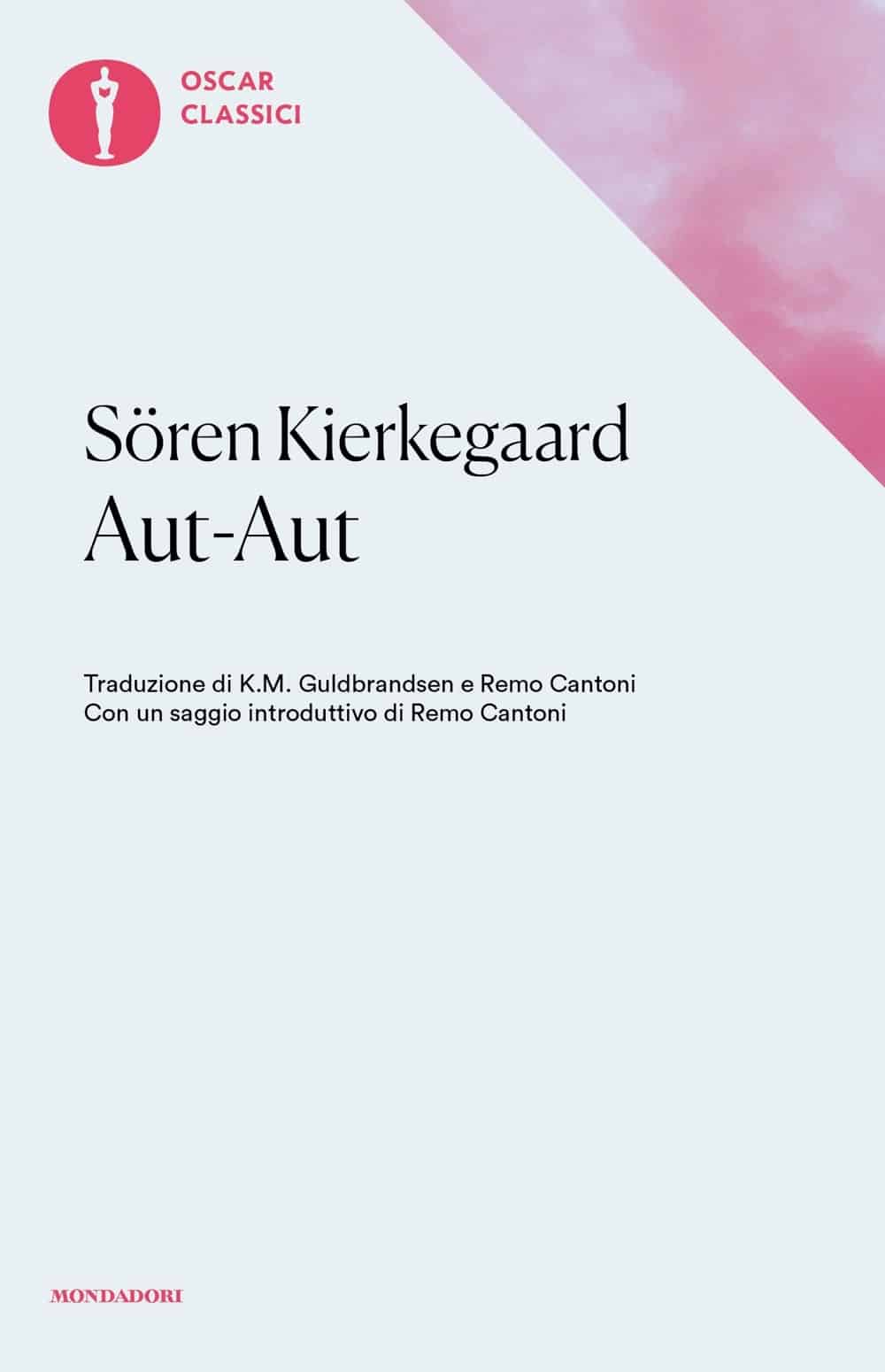
Aut Aut, del filosofo Sören Kierkegaard, considerato il padre dell’esistenzialismo, si presenta come una lettera dal tono informale in cui un personaggio fittizio,…