
“Il futuro è nostro”: il peso di una responsabilità
Io e la mia eco-ansia Avevo solamente sette anni quando, sul mio diario segreto dell’epoca, cominciai a scrivere dell’estinzione del Panda Rosso, del riscaldamento globale…



Io e la mia eco-ansia Avevo solamente sette anni quando, sul mio diario segreto dell’epoca, cominciai a scrivere dell’estinzione del Panda Rosso, del riscaldamento globale…
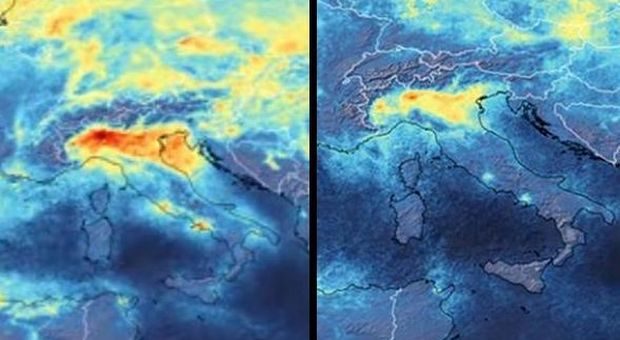
Il rispetto dell’ambiente è un principio che viene insegnato ai bambini dai primi anni di scuola per sensibilizzarli al più grande problema della nostra umanità:…

La grande sensibilizzazione in atto sui temi del cambiamento climatico sta avendo un “effetto- eco” molto positivo. La sempre maggiore comprensione del fenomeno, oltre che…
Chi lo doveva dire che un bruco comunemente usato come esca dai pescatori fosse in grado di biodegradare il polietilene, o PE, una delle plastiche…