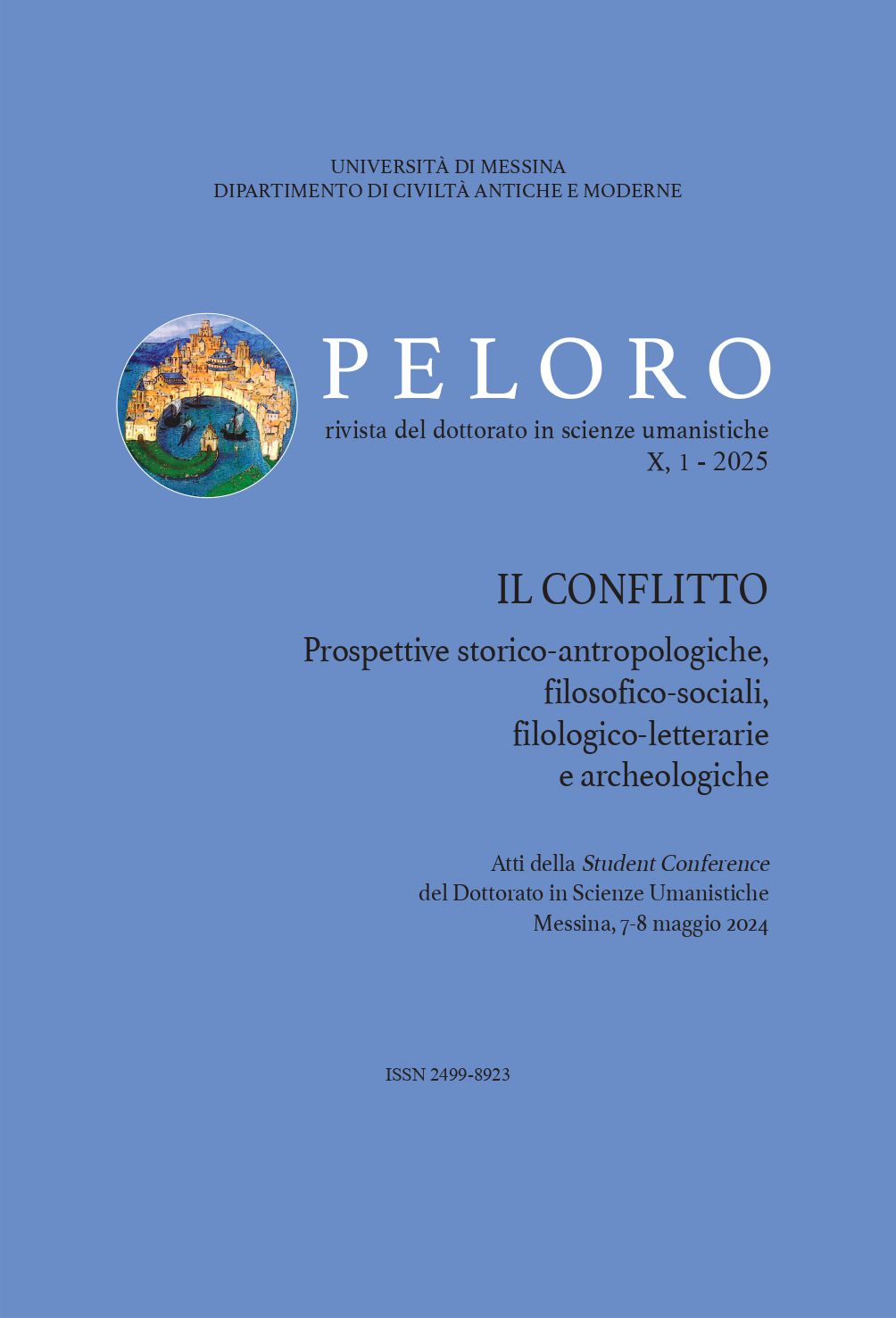
Su Peloro gli atti della Student Conference “Il Conflitto”
È online sul numero X di Peloro. Rivista del Dottorato in Scienze Umanistiche la prima sezione degli atti della Student Conference Il Conflitto. Prospettive storico-antropologiche,…


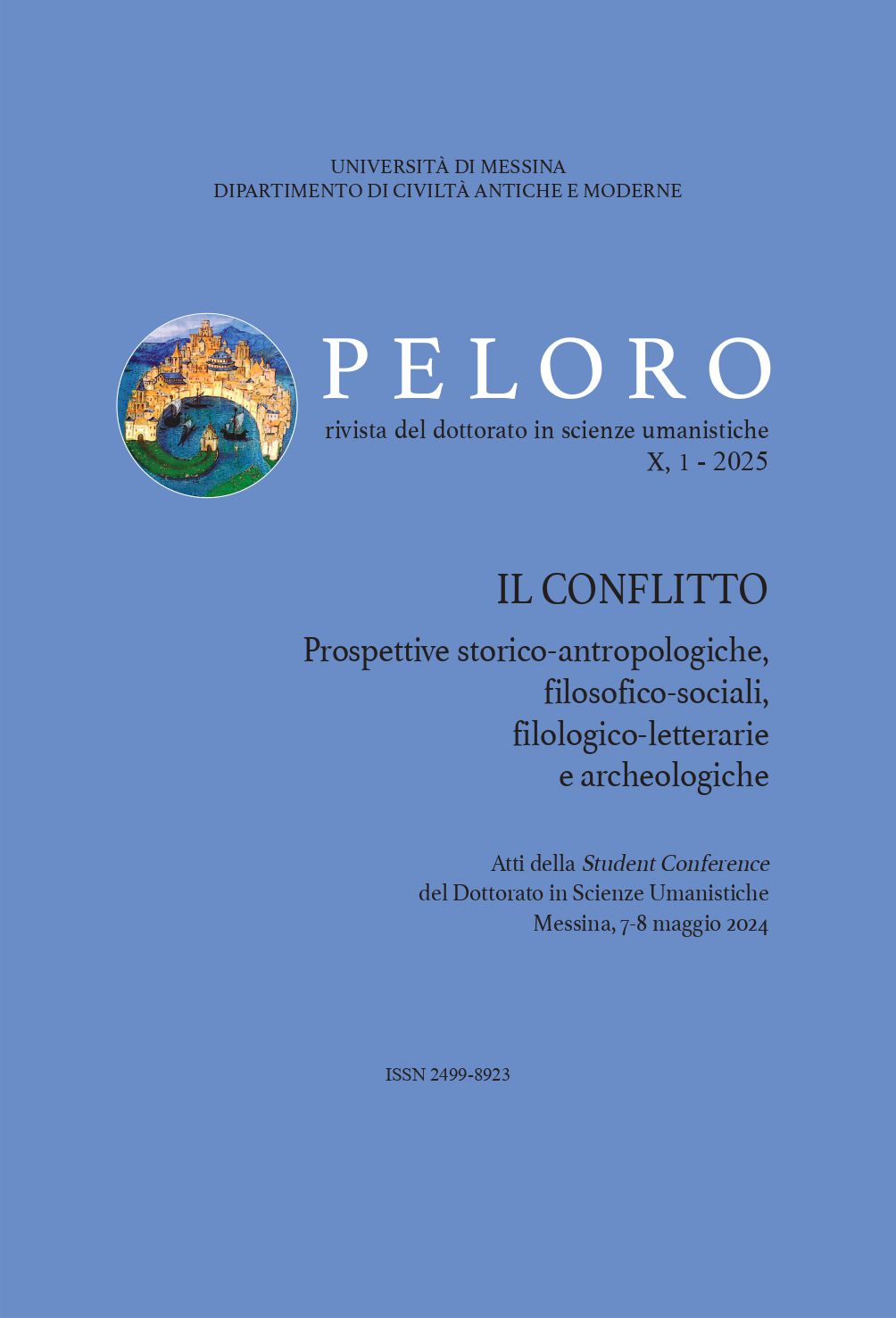
È online sul numero X di Peloro. Rivista del Dottorato in Scienze Umanistiche la prima sezione degli atti della Student Conference Il Conflitto. Prospettive storico-antropologiche,…

La recente ristrutturazione del DICAM ha restituito decoro al polo universitario dell’Annunziata, ma lo stato di abbandono dell’omonimo Viale penalizza l’immagine del Dipartimento. Basta fare…

Nato nel marzo 2015 DICO – Dubbi sull’Italiano Consulenza Online festeggia oggi dieci anni di attività. Per celebrare questo traguardo, l’Ateneo ha organizzato l’evento “Vivere in…

Il 7 e 8 maggio si terrà al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina un convegno dal titolo “Il conflitto: prospettive storico-antropologiche,…

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne ha organizzato due incontri seminariali con il noto inviato speciale Valerio Pellizzari, svoltisi mercoledì 8 novembre (ore 10:30)…

Lunedì 1 aprile 2019. Ore 15:40. Auditorium del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. L’associazione Must, ha dato vita ad un incontro…

Giovedì 28 marzo 2019. Ore 16.30. Piazza Pugliatti. Rettorato. Accademia Peloritana dei Pericolanti. Lucio Presta, agente e produttore dello spettacolo, ha presentato il suo nuovo…

“Quando il tuo sguardo passa sulla terra di nessuno, non c’è letteralmente niente che balza all’occhio se non una sofferente desolazione di nulla. Al primo…
Si è tenuto martedì, presso il Dipartimento di Cività Antiche e Moderne, l’incontro organizzato dall’Associazione Universitaria Atreju che ha visto come protagonisti i giovani e…