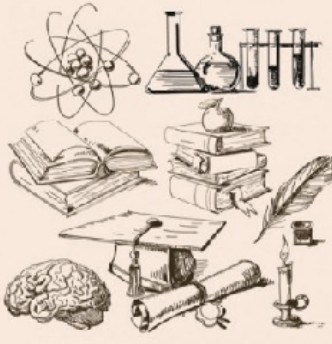Nessuna immagine disponibile
Perché Darwin aveva ragione
Semplice, elegante, efficace. La teoria dell’evoluzione descrive come gli organismi di una popolazione si evolvono nel tempo ed in relazione alle condizioni dell’ambiente. Si tratta probabilmente…