
FRU 2025, la scintilla della comunicazione
Prologo: la radio vista da fuori Il me stesso di qualche mese fa vedeva la radio come un semplice strumento di trasmissione di tracce musicali,…



Prologo: la radio vista da fuori Il me stesso di qualche mese fa vedeva la radio come un semplice strumento di trasmissione di tracce musicali,…

Cosa sia il cinema se lo sono chiesti in tanti nel corso della storia. Dai fratelli Lumière alle sorelle Wachowski, passando per Woody Allen, Godard,…
La comunicazione umana è un ambito di studio approfondito da, relativamente poco, dalla scienza. L’interesse si è venuto a creare davvero alla nascita dei regimi…
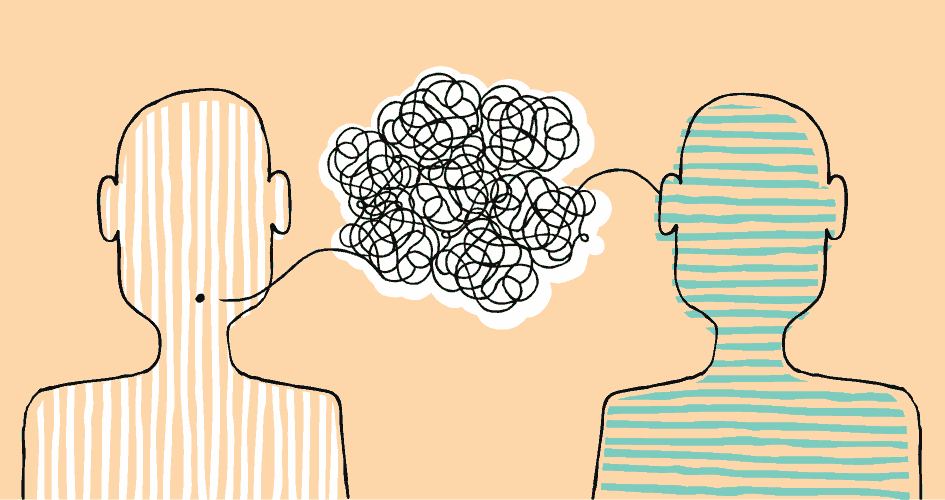
È una continua lotta a chi la spara più grossa. L’eterna ricerca dell’opinione più risonante, più provocante. Tanta scena, poca sostanza. Tanti insulti, poca informazione….
Si sa, l’UniMe ha tante eccellenze passate, presenti e, ci si augura, future. Un grande onore del nostro Ateneo, specialmente del dipartimento di Giurisprudenza, è…
Unime apre le porte alla multicanalità: nuovi canali bidirezionali di comunicazione permettono con estrema facilità di accedere e reperire le più svariate info. Il…

Salvini, paura e populismo: non è il metodo Burioni che salverà i bambini italiani. L’ultima entrata in scivolata contro il mondo dei vaccini risponde al…