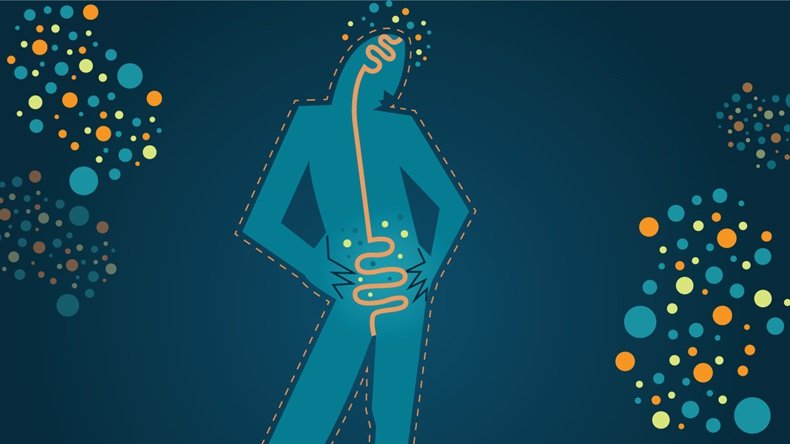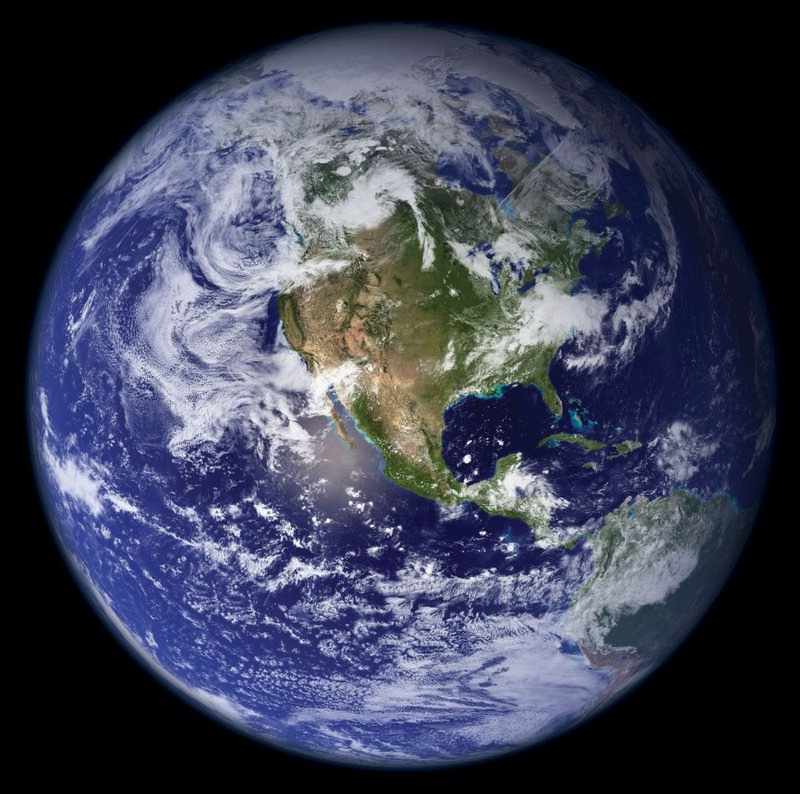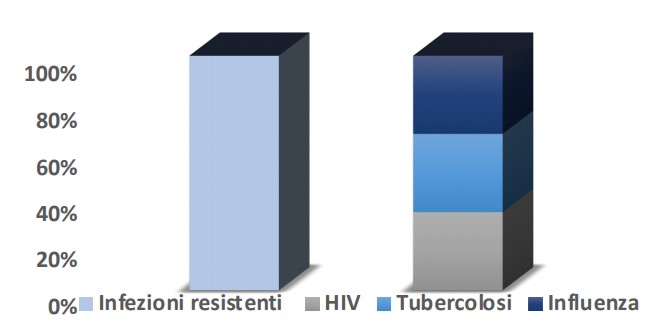Dagli studenti per gli studenti: quali sono i meccanismi di trasmissione nei batteri?
I batteri sono microrganismi unicellulari, aploidi, in grado di riprodursi autonomamente nell’ambiente e anche in vari tessuti del corpo umano; vengono utilizzati per questo nei laboratori….