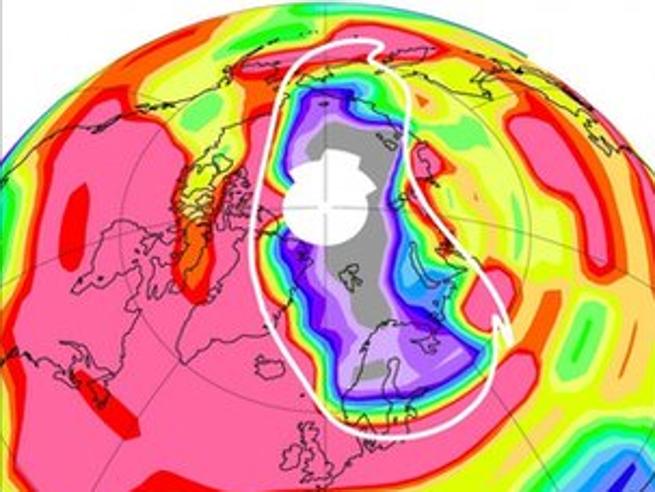Proteste pacifiche in Russia per la scarcerazione di Navalny, migliaia in manette. USA e UE: “è violazione dei diritti umani”
Sono oltre 4mila i manifestanti fermati durante le proteste di sabato e domenica in Russia, contro la detenzione dell’oppositore, l’unico, di Putin, Aleksej Navalny. Navalny…